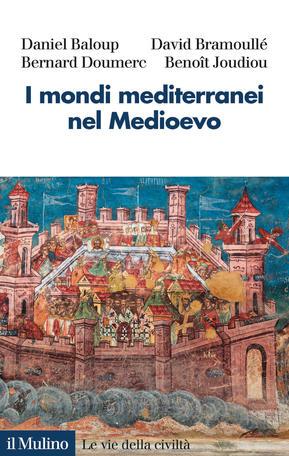Se per gli antichi romani il mar Mediterraneo era il “Mare nostrum”, per quelli che si affacciavano sulle sue sponde durante l’era medievale divenne il “Triplex confinium”, ovvero il triplice confine che divideva, e univa, Africa, Asia ed Europa. Nel libro “I mondi mediterranei nel Medioevo” (casa editrice il Mulino, 305 pagine, 25 Euro) un team di autori di grande valore (D.aniel Baloup, David Bramoullé, Bernard Doumerc, Benoit Joudiou) disvela le identità e le culture mediterranee in epoca medievale: il volume, infatti, non è una sintesi delle vicende che hanno avuto come scenario il grande mare che unisce i tre continenti, ma nelle intenzioni degli autori il testo vuole presentare la grande varietà storica, politica e culturale che va al di là dell’idea di un contesto omogeneo o binario, cioè ridotto all’opposizione tra cristianesimo e Islam, per focalizzare l’attenzione proprio sull’incontro, a volte pacifico altre aggressivo, tra mondi diversi, nuovi e in continua evoluzione.
La storia del Mediterraneo medievale è fatta di fasi di espansione e di contrazione, all’interno delle quali si muovono mondi diversi eppure contigui e non sempre in conflitto tra di loro: i commercianti veneziani sanno bene che le frontiere possono essere valicate, l’emiro di Chaysar presta la sua moschea ai Templari per le loro preghiere, il sultano Mehmet II dopo aver conquistato Costantinopoli accorda ai genovesi uno statuto molto generoso, le dinastie berbere che difendono Al Andalus dalla conquista cristiana accettano l’insediamento di nuove diocesi cattoliche in Africa del nord.
Proprio queste vicende presentano il Mediterraneo come “Triplex confinium”, zona condivisa tra Africa, Europa e Asia, che si caratterizza dalla mescolanza prodotta dallo spostamento dei luoghi del potere, dagli scambi economici e commerciali e da un serrato confronto culturale: i musulmani recupereranno gran parte del sapere antico greco-romano, sapere che, tramite i dotti cristiani che si recavano a studiare in Al Andalus, sarebbe poi ritornato sui banchi e nelle lezioni delle università europee.
Il libro porta uno sguardo originale su questo turbolento crogiolo, cogliendolo nella sua complessità non riducibile alla mera contrapposizione fra civiltà (cristianesimo e Islam, come si è detto). La prima parte del saggio tratta la frammentazione dell’unità mediterranea romana, il controllo delle isole e degli stretti, il rapporto con l’entroterra; la seconda, la costruzione di società diverse, la convivenza e lo scontro fra religioni e identità differenti, l’integrazione dei migranti; la terza, la circolazione terrestre e marittima, le diaspore, gli scambi culturali.
Massimiliano Palmesano