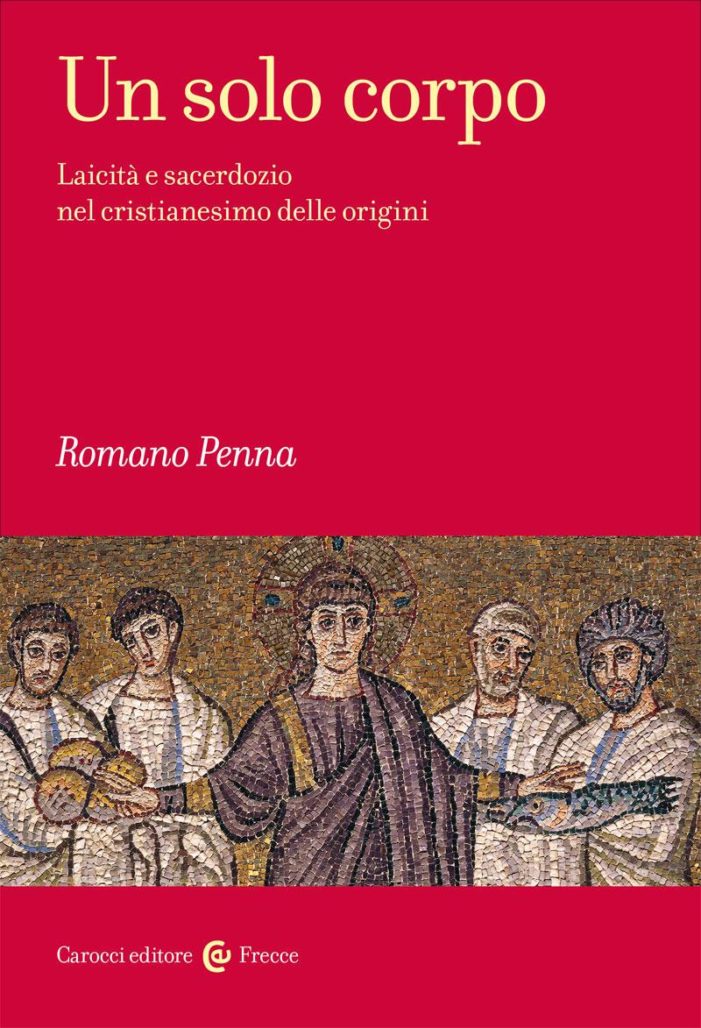La diversificazione tra laici e sacerdoti è uno dei tratti caratteristici del cristianesimo, ma all’interno della religione rivelata da Gesù di Nazaret non sempre l’organizzazione della comunità dei fedeli è stata contraddistinta da questo assetto. Anzi, nel cristianesimo dei primi secoli di questa differenza tra laici e sacerdoti pare che non se ne ritrovino tracce, così come evidenzia Romano Penna nel suo libro “Un solo corpo – Laicità e sacerdozio nel cristianesimo delle origini” (Carocci editore, 247 pagine, 23 Euro) in cui analizza l’organizzazione e la fisionomia della religione cristiana dalla sua nascita fino agli albori del IV secolo e cioè nelle fasi cruciali della sua fondazione. Nei testi più antichi del movimento religioso sorto nel nome di Gesù, che sono tra l’altro anche i testi cosiddetti canonici e cioè normativi, questa differenziazione non compare.
Al contrario, da un’attenta analisi esegetica traspare uno scenario differente: nei testi antichi emerge a più riprese la necessità di una convergenza paritaria di tutta l’ekklesia, ovvero della comunità dei fedeli, nel costruire tutti insieme la nuova realtà collettiva, come si evince chiaramente ad esempio dalla metafora del corpo che caratterizza le lettere di san Paolo e che è centrale in Romani (12,5), 1Corinzi (10,16-17), Efesini (4,4 ; 5,30) e Colossesi (1,18). I testi antichi parlano della neonata comunità cristiana come di un complesso sistema sociale in cui si collocano paritariamente giudei e greci, schiavi e liberi, uomini e donne, ma anche i ministri ecclesiastici, che non vengono mai chiamati sacerdoti e sono posti sullo stesso piano di tutti gli altri membri della comunità, che non vengono mai definiti laici, senza antagonismi tra i due ambiti che erano esclusivamente investiti da funzioni differenziate.
Lo studio dei testi cristiani fondativi proposto nel libro di Romano Penna, che si basa soprattutto su di una comparazione con l’ambiente religioso del tempo sia greco sia ebraico, delinea uno scenario che per molti aspetti è sconosciuto e che rappresenta la vera essenza del fenomeno storico-comunitario conosciuto con il nome di cristianesimo. Il saggio di Romano Penna, proprio per questa profonda opera analitica, ha la doppia valenza di essere da un lato un utile strumento di studio anche per gli estranei alla fede cristiana, dall’altro quello di restituire ai fedeli cristiani stessi un prezioso pezzo di memoria sugli effettivi e luminosi inizi storici della loro speciale identità.
Massimiliano Palmesano