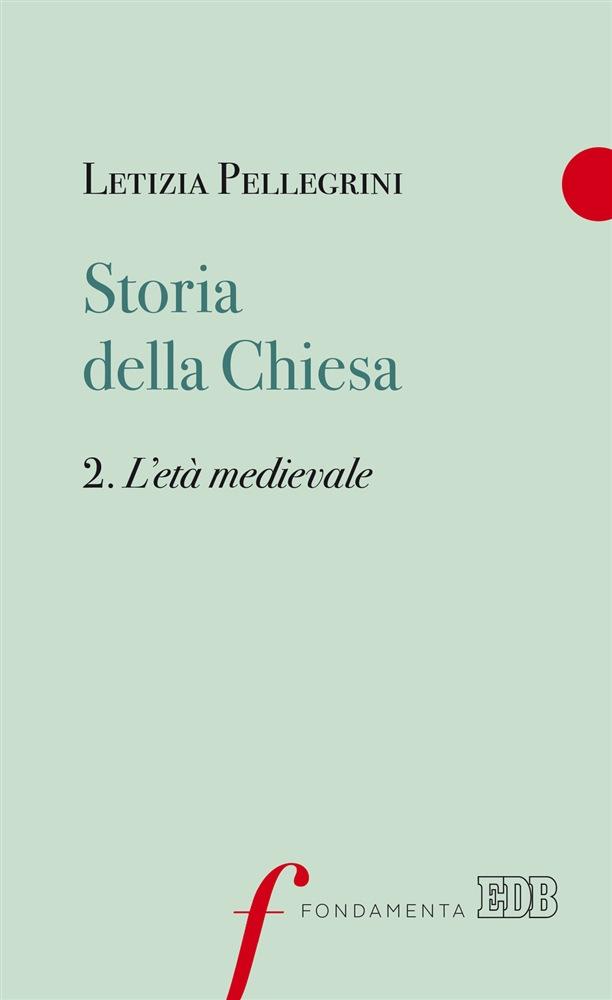Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative editoriali concentrate sulla storia del cristianesimo e in particolare della chiesa cattolica romana, segno di un rinnovato interesse verso le tematiche religiose. In particolare sta fiorendo un nuovo paradigma di studi sulla chiesa dei primi secoli e su quella medievale con la pubblicazione di saggi molto dettagliati, come ad esempio il volume di Letizia Pellegrini, “Storia della Chiesa – 2. L’età medievale” (Edizioni Dehoniane, 333 pagine, 29 Euro), che è parte di una collana dedicata alle vicende ecclesiastiche curata dalla casa editrice bolognese. Il libro approfondisce la storia della chiesa di Roma durante il lungo periodo che va dalle origini del monachesimo fino alla seconda metà del 1400.
Quando ci si riferisce ai millennio in questione, nel linguaggio comune ci si trova spesso al cospetto di percezioni diametralmente opposte: da un lato l’idea di un Medioevo ridente, una sorta di tenera infanzia dell’Occidente moderno con l’aura mitica che avvolge cavalieri e santi, trovatori e monaci copisti, e culla di grandi monumenti quali Castel del Monte ed esperienze quali il cammino di Santiago; dall’altro resiste il collaudato e antico stereotipo che vede nel Medioevo un’epoca oscurantista e feroce, contraddistinta dalla barbarie delle crociate e delle fiamme dei roghi inquisitoriali, ma soprattutto dalla misoginia del potere, in particolar modo di quello ecclesiastico. Due modi di guardare e pensare al Medioevo molto diversi tra loro ma che hanno origine entrambi da meccanismi sviluppatisi proprio all’interno della storia della Chiesa: dall’esaltazione della funzione provvidenziale, salvifica e unificatrice, al biasimo della prepotente violenza ispirata dalla teologia, dalle crociate e dalla persecuzione di eretici e streghe.
Il libro di Letizia Pellegrini attraversa in modo preciso e minuzioso la serie di fattori che hanno generato questi luoghi comuni, tracciando un racconto del Medioevo ecclesiastico con l’accuratezza che va richiesta a un lavoro storiografico. Dalle pagine del volume traspare in modo chiaro che non esistono né leggende nere né leggende auree, ma solo interpretazioni degli avvenimenti che vanno storicizzate essendo state formulate, rispetto alle vicende medievali, rispettivamente dalla cultura illuministica e da quella romantica. Il saggio, rigoroso e al tempo stesso agile, si rivolge al pubblico universitario, alle facoltà teologiche, agli istituti di scienze religiose e ai seminari, ma è un utile strumento di approfondimento per tutti, grazie all’utilizzo da parte dell’autrice di un linguaggio chiaro e non tecnicistico.
Massimiliano Palmesano