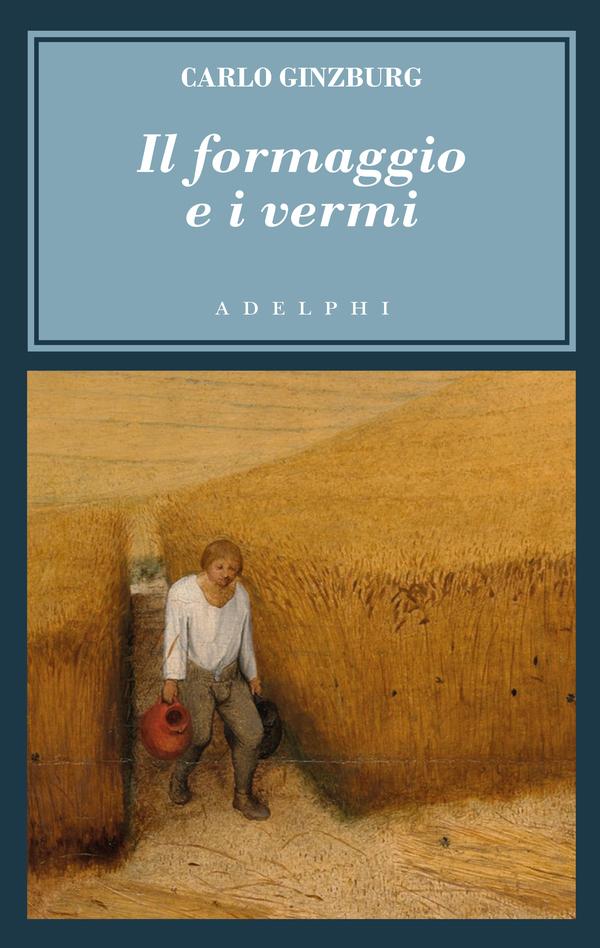Si chiamava Domenico Scandella, viveva a Montereale Valcellina, in Friuli nel 1500, e faceva il mugnaio. La gente del paese lo conosceva con il nome di “Menocchio”, i giudici della Santa Inquisizione lo processarono e lo condannarono a morte come eretico per le sue idee. La storia di questo mugnaio dal “cervello sottile” è raccontata nelle pagine de “Il formaggio e i vermi”, saggio storico di Carlo Ginzburg, di cui è uscita da poco la ristampa per la casa editrice Adelphi (231 pagine, 24 euro). Pubblicato la prima volta nel 1976, Adelphi riporta sul mercato del libro italiano uno dei saggi più interessanti e avvincenti di Carlo Ginzburg che, ancora giovanissimo, ritrovò tra alcuni faldoni di processi inquisitoriali celebrati in Friuli le carte degli interrogatori e della condanna a carico del mugnaio Domenico Scandella. “Menocchio” gestiva due mulini in fitto e alcuni terreni a livello, era un lavoratore e un padre di famiglia, ma aveva una sua particolare idea della religione e sognava un “mondo nuovo e un nuovo muodo de vivere”. La sua più grande colpa, nell’Europa della Controriforma, fu quella di saper leggere e scrivere. “Menocchio”, infatti, nei modi più disparati riuscì a procurarsi dei libri, dalla Bibbia in volgare al Decamerone, fino al Corano, e ne assimilò i contenuti, mischiandoli poi con un complicato e antico sostrato di credenze popolari e contadine. Ne ricavò una sua singolarissima cosmogonia, secondo la quale in principio era il caos, una massa indistinta, dalla quale nacquero Dio e gli angeli – così disse – come nascono i vermi dal formaggio. Le idee di Domenico Scandella (1532-1599) furono motivo di attenzione da parte dell’Inquisizione, che lo portò a processo per ben due volte, condannandolo infine a morte come eretico, negli stessi anni in cui, a Roma, era giustiziato Giordano Bruno (17 febbraio 1600).
Carlo Ginzburg, con magistrale acume, ci conduce nel mondo di “Menocchio”, nelle sue abitudini, nei suoi sogni, ricostruendone stile di vita, letture e aspirazioni, in un lungo viaggio dove la ricerca storica va sempre di pari passo con quella antropologica e socio-economica. Si tratta di uno spaccato non solo sulla vita del mugnaio di Montereale, ma in generale sugli stili di vita e la spiritualità delle classi subalterne, popolari e contadine, agli albori dell’età Moderna. “Il formaggio e i vermi”, per questa sua vocazione multidisciplinare, e soprattutto per la singolare vicenda del protagonista, resta uno dei lavori più significativi di quello che, a ragione, è considerato tra gli storici più importanti del nostro tempo, con all’attivo pubblicazioni tradotte in tutto il mondo. Libri che hanno affascinato e affascinano tantissimi lettori e ispirano numerosi nuovi studi.
Massimiliano Palmesano