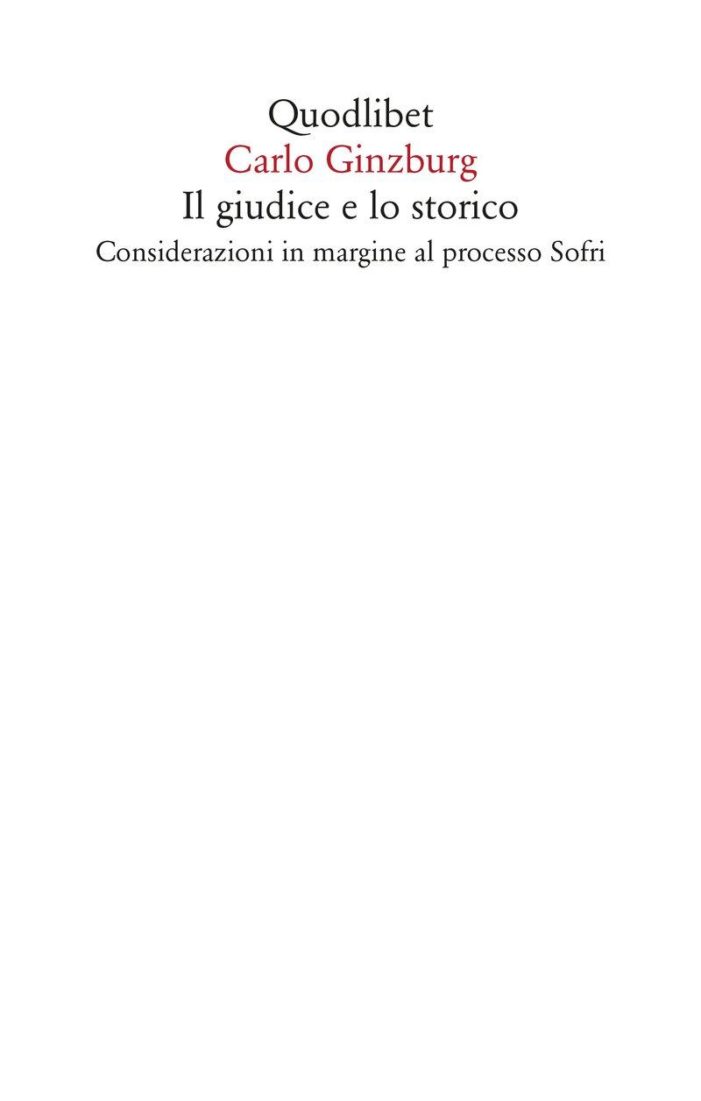Carlo Ginzburg, uno dei più grandi storici viventi, e Adriano Sofri, scrittore, ex leader di Lotta Continua e protagonista di una delle vicende giudiziarie più complesse della storia repubblicana, sono amici. Con questa premessa il professor Ginzburg apre “Il giudice e lo storico – Considerazioni in margine al processo Sofri” (Quodlibet, 174 pagine, 14,50 Euro), libro che dalle prime battute si configura agli occhi del lettore con una doppia valenza: da un lato un minuzioso lavoro di ricostruzione storica del processo, dall’altro una profonda riflessione metodologica e storiografica che travalica i confini dell’episodio particolare per abbracciare considerazioni di carattere generale.
I fatti analizzati nelle pagine del libro sono ben noti: il 12 dicembre 1969 a piazza Fontana a Milano esplode un ordigno che provoca 17 morti e 88 feriti. Partono le indagini e, tra gli altri, il ferroviere anarchico Pino Pinelli è convocato in Questura per accertamenti; dopo tre notti, il 15 dicembre, il suo corpo vola dalla finestra dell’ufficio del commissario Luigi Calabresi. Sulla sua morte saranno fornite versioni diverse e contrastanti: Lotta Continua, attraverso le colonne del suo quotidiano, mette in campo una dura campagna di stampa all’indirizzo del commissario Calabresi. Nel 1972, il 17 maggio, Calabresi viene ucciso a colpi di pistola sotto casa. Intorno alla vicenda vengono costruite diverse ipotesi ma nessuna di esse sembra voler portare a una conclusione finché, dopo sedici anni, un ex operaio della Fiat, già militante di Lotta Continua, Leonardo Marino, decide di costituirsi e confessa al sostituto procuratore Ferdinando Pomarici di aver preso parte all’omicidio del commissario Calabresi, chiamando come corresponsabili Giorgio Pietrostefani, Adriano Sofri e, come esecutore materiale, Ovidio Bompressi: inizia così l’odissea dei processi.
Questo lo scenario che si ritrova ad analizzare Carlo Ginzburg, che di processi, e delle dinamiche psicologiche che ad essi soggiacciono, è un profondo e attento conoscitore fin dai primi tempi della sua lunghissima carriera di storico. Ginzburg infatti a partire da “I Benandanti”, e passando attraverso altri due suoi fondamentali lavori che sono “Il formaggio e i vermi” e “Storia Notturna”, ha focalizzato la sua attenzione su processi celebrati dal Santo Uffizio all’indirizzo di eretici, guaritori contadini, streghe e appartenenti agli strati sociali subalterni, tra Medioevo ed era moderna. Con lo stesso acume con cui ha studiato e decifrato i processi di secoli fa, ha costruito una griglia per districare i numerosi nodi del processo a carico dell’amico Sofri e per dimostrarne l’innocenza, di cui il professor Ginzburg si dice certo. Per farlo, in linea con la sua inconfondibile cifra stilistica, pur ammettendo un leggero spaesamento a causa della vicenda che lo tocca così da vicino, Ginzburg mette a confronto diverse versioni dei fatti fornite in interrogatori avvenuti in tempi diversi, ricostruisce gli avvenimenti e i contesti in cui sono avvenuti, ma soprattutto traccia delle evidenti similitudini tra i processi celebrati dall’Inquisizione e quello contro Sofri, Bompressi e Pietrostefani. Anche in questo caso infatti il reo confesso, Leonardo Marino, oltre a costituirsi trascina nel processo con le sue accuse altre persone, proprio come avveniva per molte streghe che, sotto forti pressioni psicologiche dei giudici, fornivano i nomi di altri presunti partecipanti al sabba. Soprattutto però quella che viene a galla è una stretta relazione, più volte indagata da Ginzburg, tra giudice e storico, a partire dal corollario delle domande che molto spesso accomuna le due figure: anche lo storico interroga le fonti allo stesso modo in cui il giudice interroga gli imputati e i testimoni. Ginzburg inserisce delle immagini prese in prestito dalla storia, dalla filosofia, dal diritto, per smontare in maniera argomentata le presunte prove prodotte contro Sofri. Un libro che oltre ad accendere i riflettori su una vicenda che è ancora per molti aspetti oscura, fornisce una riflessione profonda sulla funzione morale della storia. L’ex leader di Lotta Continua, nonostante la condanna, è libero dal 2012 per decorrenza della pena, ridotta a 15 anni per effetto dei benefici di legge; da allora spesso lo si vede accompagnare il suo caro amico Ginzburg durante le sue conferenze e gli incontri pubblici, il professore ogni tanto gli lancia un’occhiata e forse in Sofri rivede un moderno e meno sfortunato Menocchio, il mugnaio friulano protagonista di uno dei suoi libri, condannato a morte dal Santo Uffizio a causa della fede incrollabile nelle sue idee.
Massimiliano Palmesano