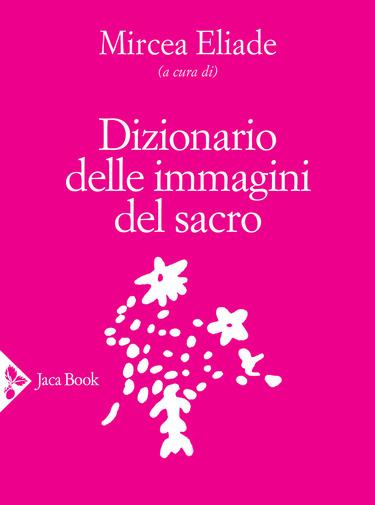L’essere umano ha sempre rappresentato il suo rapporto con la sfera del sacro attraverso la creazione e l’utilizzo di immagini, di simboli che racchiudevano significati religiosi e spirituali. Per secoli, o forse addirittura per millenni, il sacro si è rivelato per mezzo di segni grafici che sin dalla loro origine non hanno voluto esclusivamente rappresentare in modo descrittivo la realtà, bensì erano veicoli di trasmissione e di diffusione di significati e poteri spirituali. Il “Dizionario delle immagini del sacro” (Jaca Book, 198 pagine, 35 Euro) dà la possibilità di orientarsi all’interno della composita congerie di elementi e simboli religiosi che hanno caratterizzato il rapporto con l’insondabile mondo del sacro fin dalla notte dei tempi.
Un dizionario che è stato realizzato a partire dagli studi e dalle riflessioni dello storico delle religioni Mircea Eliade, ma che vede al suo interno testi e studi di Julien Ries, Juan Plazaola, Tania Velmans e altri importanti autori che si sono occupati di sacro e simbolismo. Proprio uno degli autori presenti nel dizionario, e cioè lo storico delle religioni Julien Ries, in accordo col paleoantropologo Yves Coppens, mise in risalto la coscienza di creatore dell’Homo habilise come questa coscienza abbia indotto i nostri antenati a non cessare mai di fare nuove scoperte e creazioni: sin dalla sua comparsa sulla terra l’uomo ha assunto quelle caratteristiche che gli hanno valso l’appellativo di Homo simbolicus, creatore di ritmi, suoni, forme, immagini.
Non sappiamo precisamente quando la potenza incarnata dai simboli sia comparsa nell’orizzonte psicologico dell’essere umano, forse proprio la nostra capacità immaginifica instillò nei primi uomini l’intuizione di rappresentare i propri pensieri attraverso i simboli, di materializzare le idee per trasformarle in logos,in ideogrammi e segni alfabetici, in linguaggi, in verbo fatto carne come ci suggeriscono i testi biblici. Forse le immagini giungono solo in seguito a un lungo periodo di evoluzione e crescita, ma già centinaia di migliaia di anni fa le selci più belle e colorate che venivano scheggiate erano poste a decorazione delle sepolture, uso che rivive ancora oggi nella pratica di omaggiare i defunti con mazzi di fiori. Già decine di migliaia di anni fa in tutto il pianeta l’arte rupestre si caratterizzava con raffigurazioni rituali e simboliche, come nella grotta di Lascaux in Francia che è stata ribattezzata “La Sistina della preistoria” sulle cui pareti sono rappresentati imponenti animali che costituiscono la sintassi del mito. Con l’avvento della sedentarizzazione, circa diecimila anni prima della nostra era, iniziano a comparire immagini di divinità come testimonia l’abitato di Çatal Hüyük, in Turchia, immagini indispensabili all’uomo per relazionarsi col destino e col cosmo.
Il “Dizionario” affronta in modo specifico il rapporto tra le immagini del sacro e l’evoluzione dell’arte e delle culture, grazie alle importanti acquisizioni delle ricerche sulla preistoria condotte nella seconda metà del secolo scorso e sintetizzate in voci da parte di Julien Ries. Dalle pietre scheggiate dall’Homo habilisalle opere parietali e rupestri realizzate a cavallo tra paleolitico superiore e neolitico, ritroviamo immagini che fanno ormai parte del patrimonio culturale e religioso dell’umanità. L’esigenza di produrre e comunicare attraverso le immagini è da sempre straripante per l’uomo e le religioni ne sono state la sorgente maggiore, in questo senso l’intuizione di Eliade riguardo all’Homo religiosustrova conferma nel magistrale lavoro di Ries: le immagini del sacro accompagnano tutta l’evoluzione umana e vanno oltre i contesti specifici delle grandi religioni.
Massimiliano Palmesano